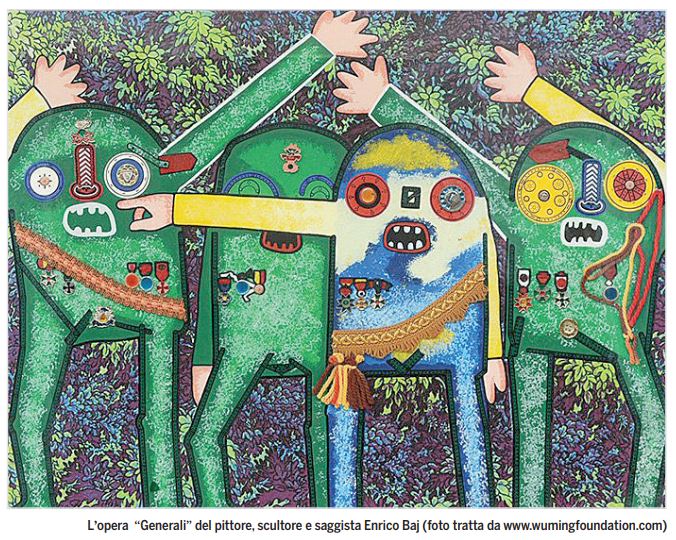L’insipido poeta
VENEZIA – Forse vi ricordate dai tempi della scuola, in un piovoso mattino di aprile, seduti irrequieti sul banco, quelle tamerici salmastre, quei volti silvani, quella favola bella che illuse anche Ermione. Dimenticateli.
O forse vi siete imbattuti in qualche filmato d’epoca in cui il Vate recita Dante con variazioni ammiccanti, ridendo in maniera puerile delle sue stesse facezie. Scordatevelo.
Lasciate da parte tutto quello che è stato scritto e detto su quel Gabriele pescarese, prima a Roma giornalista mondano e poi guerriero e poeta in giro per l’Italia.
Dopo quasi un anno di ritardo per i motivi che conosciamo, è uscito finalmente nelle sale italiane “Il cattivo poeta” per la regia di Gianluca Jodice (che firma anche la sceneggiatura) con Sergio Castellitto nei panni del protagonista e Francesco Patané in quelli del giovane federale fascista a cui viene affidato il compito di spiare la vita del poeta nel suo dorato esilio a Gardone Riviera.
Al di là della trama agilmente riassumibile, dalle trite movenze del ‘tratto da una storia vera’, di questa pellicola colpiscono molti elementi e pochi sono quelli positivi. Forse qualcuno avrebbe dovuto spiegare alla produzione il detto latino ‘nomen omen’.
Di cattivo c’è molto. E il problema non è D’Annunzio. La tanto sbandierata (su articoli e interviste) aderenza ai fatti viene meno già a partire dai dialoghi dal sapore 2010: su tutti, scompare il fascistissimo (e machissimo) ‘voi’ rimpiazzato casualmente da ‘tu’ e ‘Lei’ che volano in libertà (questa non futurista). Di ami ne vengono lanciati molti e si potrebbe pensare che i numerosi fili delle vite dei personaggi si possano argutamente intrecciare per restituire allo spettatore un arazzo raffinato e rutilante. Al contrario, la superficialità con cui sono trattati i personaggi è disarmante: non si riesce ad amare o ad odiare nessuno in questo film, non si crea empatia né per i buoni né per i cattivi. La mediocritas è ubiqua e non è aurea.
A tratti, in qua e in là, sembrano emergere degli spunti interessanti che vengono puntualmente abbandonati: forse che si vogliano sbalzare a rilievo le grandiose iconografiche eloquenza e visione dannunziane di contro alla grettezza del bruto Mussolini? O che il rapporto tra D’Annunzio e Giovanni Comini sia effettivamente andato al di là della stima, affacciandosi alle soglie del rapporto padre-figlio? Del primo si fa accenno in una battuta di una delle amanti del Vate (la pianista Luisa Baccara, interpretata da Elena Bucci); del secondo me ne faccio carico, consapevole di parlare di ciò che non ho visto (o sentito o percepito).
A fine visione, viene da dire che è uno di quei casi in cui il trailer riassume i momenti migliori. Anche le riflessioni più o meno intime stentano a farsi sentire vive e veraci, più frasi ad effetto che umanissimi sintagmi di natura introspettiva (su tutti il «Non sapevamo quel che eravamo, non sapevamo quel che volevamo. Ed ecco che sappiamo quel che siamo e quel che vogliamo» messo in bocca a Castellitto.) Il mimetismo dei costumi, del trucco, delle scene (il privilegio di aver girato nelle asfissianti stanze del Vittoriale), delle pettinature, degli alamari sulle divise può forse essere iper-realismo neo-filologico, ma non vi tragga in inganno. Non è realtà. E soprattutto, non è verità attoriale. Il film stanca: è lento, a tratti eterno, vacuo, senza scheletro, lutulento, non decolla mai.
Di questa pellicola si può dire molto e, soprattutto, quello che non è: non è romanzo di formazione, non è apologia, non è omaggio, non è un centone di raffinati camei.
È stinto, a tratti claudicante, non soffoca, non emoziona, non commuove. In fin dei conti, signori e signore, si tratta di Gabriele D’Annunzio: l’uomo che negli ultimi anni della sua vita ben poco dovette amare se stesso (quasi senza denti e quelli ancora in bocca marci, un alito dal fetore infernale, che si vergognava a mangiare insieme ad altre persone per non dover aprire quella nera voragine nauseante) e purtuttavia fu capace di ricreare e forgiare il (suo) mondo con la sola forza delle sue parole, delle sue idee, della sua alchimia iconologica. Il poeta che seppe accumulare su di sé tanti altisonanti epiteti quanti gli eroi omerici.
Colui che diceva (e lo fece incidere come motto all’ingresso del Vittoriale), con evocazione quasi francescana, “Io ho quello che ho donato”. L’uomo che a detta sua e di molti aveva assaporato i più variegati (sublimi e non) piaceri della vita si ritrova in un film in cui tutto è sciapo, insipido, sciocco. Lui che era campione nell’incrementare iperbolicamente la sapidità dell’esistenza diventa in questi infiniti 106 minuti un mozzicone di pane che non sa neppure di sale.