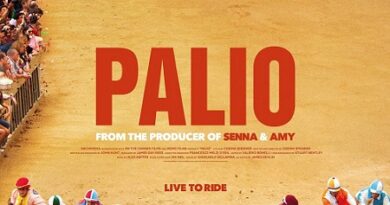In conversazione
con Angelica Pesarini
TORONTO – Abbiamo avuto il piacere di intervistare la Professoressa Angelica Pesarini, docente della nuova posizione di Race and Cultural Studies / Race and Diaspora presso il Dipartimento di Italian Studies e il Centre for Diaspora and Transnational Studies della University of Toronto. Pesarini è una delle studiose più autorevoli nel campo degli studi critici sulla razza, il genere, la cittadinanza e l’identità in Italia, ambiti di ricerca che si stanno affermando sempre di più, sia in Italia che all’estero, grazie al lavoro di una fiorente rete transnazionale di intellettuali. Tra le sue numerose pubblicazioni, Pesarini ha recentemente pubblicato “The Black Mediterranean: Bodies, Borders, and Citizenship”, curato insieme al The Black Mediterranean Collective, di cui fa parte, e edito da Palgrave Macmillan nel 2021.
La sua ricerca amplifica le storie delle persone nere in Italia, svelando come il colonialismo italiano si ripercuota ancora nel razzismo che pervade il Paese, sia in ambito istituzionale che negli aspetti della vita quotidiana. Dando voce a queste esperienze, il suo lavoro intende creare nuove epistemologie che ci aiutano a orientarci nella società in cui viviamo. Ci può parlare di questo valore trasformativo del sapere?
«Queste mie riflessioni sono maturate durante gli anni del dottorato, quando ho dovuto trovare delle metodologie che mi aiutassero a tradurre i dati che avevo a disposizione anche in relazione alla mia posizionalità di ricercatrice. Ho passato il primo anno di dottorato quasi interamente a leggere e studiare il periodo coloniale e mi ricordo di aver provato un grande disagio rispetto alla mia ignoranza su un periodo storico così importante che non avevo mai avuto modo di studiare prima. Il colonialismo ha ripercussioni visibili tutt’oggi, tuttavia, senza le lenti giuste per vederlo, queste ripercussioni sembrano invisibili. In questo senso, il pensiero femminista nero mi ha aiutato moltissimo ad applicare la lente intersezionale in quello che facevo, studiavo e vivevo come ricercatrice con una storia familiare che deriva proprio da quel periodo. Mi sono così resa conto che ci sono molti aspetti del colonialismo italiano che non ci vengono insegnati. Per lungo tempo una certa storiografia dominante ci ha fornito un’immagine romanticizzata e edulcorata del colonialismo descritto all’insegna del mito degli “Italiani brava gente”. In realtà, indagando più a fondo, la storia è ben diversa. Seppure di durata minore rispetto ad altri progetti coloniali, anche il colonialismo italiano si è basato sull’espropriazione di terre e risorse nonché sullo sfruttamento delle persone colonizzate. L’Italia ha compiuto moltissimi crimini in quegli anni. Pensiamo a criminali di guerra come Rodolfo Graziani, chiamato “il macellaio” per la violenza delle sue campagne coloniali. È interessante notare come, alla fine della Seconda guerra mondiale, Graziani venga condannato a diciannove anni non per i crimini di guerra compiuti in Libia o in Etiopia ma per collaborazionismo con la Repubblica di Salò. Di questi diciannove anni, sconta solo quattro mesi. Pensiamo, inoltre, al mausoleo che è stato eretto alla sua memoria nel 2012 ad Affile, nel Lazio. Questi eventi ci fanno riflettere su cosa studiamo e cosa viene considerato importante da ricordare. Il pensiero femminista nero mi ha aiutato a ricercare e a mettere a fuoco le ’contro-storie’. Queste storie sono difficili da trovare perché vengono ancora viste come inadeguate o non abbastanza scientifiche e per questo sono relegate ai margini del sapere. Come docente e ricercatrice è per me invece fondamentale dare risalto a queste storie che in qualche modo scalfiscono la visione dominante di un certo sapere».
Sta attualmente lavorando a un volume sulle esperienze di due generazioni di donne nate da padri italiani bianchi e madri eritree, etiopi o somale nere nelle allora colonie italiane dell’Africa Orientale. Ci può descrivere questo progetto e cosa ha scoperto durante la ricerca?
«È stata un’esperienza che mi ha dato molto, sia a livello professionale che personale, e che mi ha permesso di entrare in contatto con una parte della mia identità che era da investigare più a fondo. In Eritrea ho avuto modo di intervistare donne nate da padri italiani bianchi che andarono in Eritrea, in Etiopia o in Somalia e che ebbero relazioni con donne locali. Dalle storie che queste donne hanno raccontato è emersa un’italianità nera che evidenzia cosa significasse essere italiane, avere un cognome italiano, avere frequentato scuole italiane e parlare l’italiano in casa ma scontrarsi con una realtà in cui, uscendo per strada, non si era nere abbastanza per essere considerate del luogo (la chiarezza della pelle era infatti lo stigma visivo dell’italianità di queste donne) e, al tempo stesso, non essere bianche abbastanza per fare parte della comunità italiana che si identificava con una certa ’purezza’ razziale. È stato interessante vedere in che modo queste donne hanno gestito il proprio bagaglio identitario e il percorso di vita che hanno fatto. Formatesi nel contesto educativo coloniale del periodo fascista in Africa orientale, queste persone crescono con il mito propagandistico dell’Italia e con una conoscenza pressoché nulla del loro Paese di nascita. In seguito al complicarsi della situazione tra Eritrea ed Etiopia, molte di loro arrivano in Italia negli anni Settanta, in nave o in aereo, e con passaporto italiano in mano. È proprio qui che, per alcune, si verifica una frattura identitaria in grado di causare una serie di traumi. Un primo trauma è sicuramente quello linguistico: si rendono conto che in Italia si parla ancora diffusamente il dialetto a discapito dell’italiano più formale, la loro lingua, e si ritrovano, per certi aspetti, tagliate fuori. Un altro trauma è il dover fare i conti con la rottura delle gerarchie coloniali. In Eritrea, per esempio, gli italiani vivevano separati dalla popolazione locale e non svolgevano certi lavori destinati invece alla popolazione locale. Gli italiani erano quindi sempre associati al potere e alla ricchezza. Una volta in Italia, invece, vedono la povertà e il degrado, e trovano scioccante che un italiano bianco, dietro al bancone di un bar, serva loro un caffè. Un’altra fonte di crisi proviene dal rendersi conto, forse per la prima volta, di essere donne nere. Presto capiscono che un passaporto italiano non le rende italiane dato che il primo fattore a definirle, in Italia, è il colore della loro pelle, indipendentemente dal proprio capitale culturale. Vivono quindi una serie di abusi e di incidenti razziali che avvengono per strada o in ospedale. Il fatto che gli italiani non fossero in grado di collocare geograficamente Etiopia o Somalia o che non si capacitassero del perché queste donne fossero in grado di parlare l’italiano segnala, già all’epoca, la rimozione della storia coloniale dall’immaginario collettivo. Il trauma quindi si incentra sul paradosso di essere invisibili e al tempo stesso ipervisibili in quanto donne italiane nere».
C’è quindi una forte componente di storie orali nel volume.
«Sì, mi ha sempre affascinato ascoltare storie di vita. Sono consapevole, tuttavia, che il mio intervento di ricercatrice nel raccogliere e nel trascrivere queste storie costituisce un filtro enorme nella narrazione. Per questo, nel volume parlo subito della mia posizionalità avvisando chi legge della mia presenza nel testo. Cerco, per quanto possibile e con i limiti appena accennati, di fare in modo che siano le storie a parlare perché esse danno voce a esperienze di un impatto enorme e di cui sappiamo davvero poco. Ho fatto molta ricerca sui collegi gestiti da preti e suore missionarie in cui sono cresciute non solo alcune delle mie intervistate ma moltissime bambine e bambini definiti “meticci”, e nelle loro esperienze si possono riscontrare similitudini con la realtà delle residential schools canadesi. Accedere a quello che accadeva in queste istituzioni di violenza non è stato facile ma queste esperienze custodiscono una parte della nostra memoria storica che rischia di andare perduta. Per me è stato un onore e un privilegio poter ascoltare queste storie di vita e per questo sento la responsabilità di doverle raccontare».
In che modo l’Università di Toronto può aiutarla a portare avanti la sua ricerca?
«L’apertura di questa posizione nel Dipartimento di Italian Studies ha fatto sicuramente da apripista. È il segnale di una riflessione seria compiuta dal Dipartimento sulla disciplina e sul potenziale dell’interdisciplinarità. Io mi sono formata in ambiti molto diversi, sociologia, antropologia, gender studies e Black studies, ma credo sia fondamentale ’contaminare’ le discipline. Nonostante si possa provare molta gratitudine per le discipline che ci hanno formato, bisogna anche essere in grado di poterle contestarle se davvero vogliamo decolonizzare le forme di produzione del sapere. Sono davvero contenta di vedere l’entusiasmo con cui le studentesse e gli studenti dell’università hanno accolto questa apertura a nuovi ambiti di studio e conoscenza riguardanti l’Italia».
È arrivata da poco a Toronto. Una prima impressione della città?
«Non ero mai stata in Canada prima di trasferirmi a Toronto. La città per adesso mi piace molto e mi stupisce il fatto che sia grande ma non troppo affollata; non so se questa discrepanza sia dovuta al lockdown, ma questo la rende sicuramente diversa da altre grandi città che conosco e in cui ho vissuto come Londra o New York. Spero solo di abituarmi all’inverno che, mi dicono, sia ahimè molto lungo. Adoro invece il fatto di abitare vicino a un lago così maestoso. Vederlo ghiacciato e poterci camminare e passeggiare è stata un’esperienza nuova. Sono curiosa di scoprire la città anche nelle altre stagioni».
Nella foto, Angelica Pesarini a Firenze