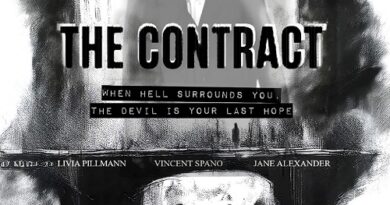“Il ritorno”, un’odissea più umana
TORONTO – Mentre quasi un terzo della popolazione mondiale ha festeggiato il Natale la scorsa settimana, un numero apparentemente uguale di cinefili, storici e antiquari è andato in delirio per l’annuncio del nuovo film di Christopher Nolan: The Odyssey (L’Odissea). Secondo la dichiarazione della Universal su X, il prossimo progetto del regista britannico “è un’epopea mitologica d’azione girata in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Il film porta per la prima volta la saga fondamentale del mitico poeta greco Omero sugli schermi cinematografici IMAX e uscirà nei cinema di tutto il mondo il 17 luglio 2026”.
Ma prima di immergerci nel potenziale capolavoro di Nolan, una supposizione basata su una filmografia quasi impeccabile, c’è un adattamento cinematografico attuale nei cinema sul ritorno epico di Odisseo di un regista italiano, Uberto Pasolini. Il ritorno riprende la storia mentre il re malconcio e consumato approda sulla sua isola, Itaca, vent’anni dopo la sua partenza. Tuttavia, l’astuto ed erudito Re di Pasolini, interpretato da Ralph Fiennes, non è ostacolato dalle divinità greche invadenti che si radicano nelle vite degli antichi Greci di Omero.
La storia di Il ritorno spoglia il racconto originale delle macchinazioni degli dei, lasciando Odisseo “Un uomo dislocato” – come dice Feinnes. “La psicologia di Odisseo è quella di un uomo che penso spostato, non so più chi sia e quindi quella psicologia che Uberto ha inserito nel testo, mi è piaciuta molto”. L’interpretazione di Fiennes prende a cuore l’insinuazione di Pasolini, poiché interpreta Odisseo con una dimensione di vergogna e rimpianto che presumibilmente non era nel progetto di Omero.
L’umanizzazione dei personaggi da parte di Pasolini, in particolare Odisseo e sua moglie Penelope, intende avvicinare il pubblico moderno al mondo antico e in un certo senso alieno, spesso pieno di dei, mostri e simbolismo mitologico di cui solo pochi sono a conoscenza. Quando gli è stato chiesto della decisione di eliminare gli dei dalla sua sceneggiatura, Pasolini ha insistito sul fatto che il suo obiettivo era esplorare il viaggio emotivo di Odisseo.
“[Catturare] la psicologia dell’essere umano, la difficoltà di essere una buona persona sarebbe difficile se ogni azione o la maggior parte delle azioni dei nostri personaggi fossero influenzate o gestite dagli dei, come dice Omero nel suo poema. Lui era un poeta, noi siamo solo semplici narratori”. In un certo senso, e questo non è inteso come un paragone denigratorio, Il ritorno di Pasolini ha più in comune con Rambo (Primo sangue, 1982) di Ted Kotcheff che con il racconto orale di Omero. Odisseo è interpretato da Fiennes come un veterano di guerra, consumato dagli orrori e dai compromessi morali delle sue esperienze a Troia e così via. È chiuso in sé, fuori posto, depresso e in definitiva non gradito: un ritratto del veterano di guerra stereotipato. Per non parlare del fatto che è diventato una macchina per uccidere.
Il ritorno, una rivisitazione ridotta del capolavoro stratificato di Omero, è la storia di un uomo emotivamente sconfitto, che lotta per riconoscere e reintegrarsi in quella che era la sua casa e il suo regno. Juliette Binoche [nel ruolo di Penelope] evidenzia tutta l’angoscia di una moglie leale che è tormentata e ha sofferto per il ritorno del marito. Da questa prospettiva, Pasolini presenta un’interpretazione interessante e ponderata, filmata in modo esperto e meraviglioso, in location nella splendida Corfù.
La sua passione per il film è evidente, come conferma Binoche: “A volte hai un ruolo nella tua vita o hai un film nella tua vita e sembrava davvero che fosse il suo film più importante. E quindi senti questo. Come se ogni singolo punto sul tessuto o il colore di questo e quello fosse così significativo per lui, allora eleva semplicemente il bisogno di un attore di trovare dentro di te qualcosa che vada oltre l’aneddoto, qualcosa che vada oltre ciò che è ovvio”.
Nelle immagini: una scena di “Il ritorno” e la locandina del film (foto per gentile concessione di 01 Distribution)
Massimo Volpe, autore di questo articolo, è un filmmaker e scrittore freelance di Toronto: scrive recensioni di film/contenuti italiani su Netflix